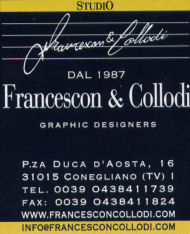L'Italia del gusto
News | Friuli-Venezia Giulia | Terre d'Acqua
IL MODELLO delle Latterie Turnarie
Notizia del 11/01/2015
La tradizione delle latterie turnarie era un tempo diffusa in tutto il Friuli. Le caratterizzava una modalità di gestione del latte semplice, economica e adatta alla produzione casearia di piccola scala tipica del territorio friulano, con numerosi allevatori sparsi in ogni borgata. L’istituzione della latteria turnaria ricalcava e formalizzava l’usanza antica di mettere insieme il latte di più famiglie e caseificare collettivamente, con lo stesso principio della panificazione che avveniva in ogni borgata.
Negli archivi storici gemonesi esiste un documento della fine del Settecento che riporta un accordo tra alcune famiglie di Osoppo per la lavorazione del latte a turno con i propri attrezzi. Attività, in quel caso, affidata completamente alle donne, così come il governo della stalla e del bestiame.
Nelle latterie turnarie la settimana è scandita attribuendo ciascuna giornata di lavorazione a un determinato socio in funzione della quantità di latte conferita. Gli allevatori che portano una quantità maggiore di latte hanno diritto a più giornate, magari stabilite in modo fisso sul calendario settimanale, gli altri le giornate di lavorazione rimanenti. Le forme una volta asciugate vengono ritirate dal socio che provvede a stagionarle nella propria cantina e a commercializzarle direttamente.
Il terremoto del 1976 ha portato alla chiusura di molte stalle e alla concentrazione degli allevamenti. Le latterie rimaste si sono mantenute ancora per pochi anni e poi hanno iniziato a chiudere per la progressiva scomparsa dei piccoli allevamenti familiari a causa di una politica agroalimentare che ha spinto i produttori a riunirsi o ad aderire a consorzi di grandi dimensioni per ottenere una maggiore penetrazione nel mercato della grande distribuzione che in quegli anni si stava affermando.
Oggi le latterie turnarie in Friuli si contano sulle dita di una mano, sono strutturate in pratica come cooperative di servizi, non essendo più possibile definirle legalmente come società di fatto. Il numero continua a calare di anno in anno poiché i soci diminuiscono, spesso sono anziani con poche vacche in stalla che cessano l’attività. Se i volumi di latte lavorati calano eccessivamente non è più economico mantenere in piedi la struttura di caseificazione e la latteria chiude.
Le latterie turnarie di Buja e Campolessi lavorano una trentina di quintali di latte al giorno, proveniente da numerose stalle di piccole dimensioni (2-4 vacche) e da alcuni allevamenti di medie dimensioni (alcune decine di capi). Il conferimento del Presìdio da parte di Slow Food è finalizzato a preservare un modello di produzione unico. Il formaggio è a latte crudo, ottenuto senza l’utilizzo di fermenti preconfezionati perché proveniente da piccoli allevamenti situati a breve distanza dalle latterie, allevamenti dove la razza più diffusa è la locale pezzata rossa. I due caseifici fanno uso di protocolli rigidissimi, che comportano un’alimentazione a base di fieno al quale si aggiunge erba fresca dalla tarda primavera fino al termine dell’estate, sono assolutamente esclusi gli insilati. Inoltre in varie stalle si pratica la stabulazione libera garantendo benessere e salute agli animali.
L’atteggiamento con il quale l’Ecomuseo e Slow Food vogliono difendere le latterie turnarie non è nostalgico e romantico ma intende dimostrare che le microeconomie possono costituire un forte motore di sviluppo per l’intero territorio. La vera sfida che viene portata avanti è tutta incentrata sulla qualità, perché promuovere e valorizzare il formaggio di questi piccoli caseifici a partire dal prezzo di vendita può aiutare ad arginare la chiusura definitiva del sistema antico che sta alla base del prodotto.
Torna a inizio pagina