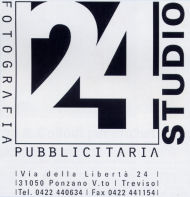L'Italia del gusto
News | Emilia-Romagna | Terre d'Acqua
Il Gran Bosco della Mesola - Itinerari naturalistici: Mesola e il Delta del Po
Notizia del 14/12/2014
L'attuale superficie del Gran Bosco della Mesola costituisce la parte residua di un complesso boscato, un tempo più vasto, originatosi in epoca successiva al 1000 per opera degli apporti dei vari rami del Po, ad Est dell'Abbazia di Pomposa.
Notizie certe di questo territorio, denominato Mesola, si hanno nel 1490 con l'atto di acquisto da parte dei duchi d'Este.
La foresta, originatasi sembra naturalmente, rimase di proprietà della Casa d'Este sino al 1758 e successivamente dello Stato Pontificio e di altri proprietari.
Nel 1954, essendo minacciata di distruzione, fu acquistata dall'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali ed attualmente viene gestita dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste.
Nel 1971 è stata istituita la Riserva Naturale Integrale "Bassa dei Frassini Balanzetta" (220 ettari) e nel 1977 la rimanente parte è divenuta Riserva Naturale.
La vegetazione del Gran Bosco è costituita prevalentemente da specie mediterranee; tra cui primeggia il Leccio consociato con quercia Farnia, Frassini, Olmi, Pioppi bianchi e Carpino orientale. Sono diffusi, prevalentemente nella zona a confine con il mare, il Pino domestico e marittimo; nel sottobosco si trovano la Fillirea, il Ligustro volgare, il Biancospino, il Pruno spinoso, il Pungitopo, il Cisto, la Felce aquilina e la Felce palustre.
A seguito delle devastazioni avvenute durante la guerra, una grande parte del bosco ha subito tagli massicci, trasformandosi in bosco ceduo; oggi si eseguono interventi colturali per riportarlo al primitivo stato di alto fusto.
Il terreno, tutto di origine alluvionale, consiste di sabbie con poco humus in superficie; l'andamento irregolare pone in evidenza antiche dune ricoperte dalla lecceta sempreverde, con spazi interdunali in cui si formano ristagni d'acqua con vegetazione palustre e piante a foglia caduca.
La quota massima è di tre metri sopra il livello del mare e, nelle depressioni, di circa un metro sotto. Vi sono radure naturali, una delle quali, detta "Parco delle Duchesse", è ampia circa 2 ettari e vi vegetano varie specie erbacee dette "pioniere" che danno l'idea della lenta colonizzazione ancora in atto su queste sabbie.
La fauna era molto varia e numerosa già in epoca estense. Narrano le cronache di quei tempi che i duchi facevano spargere mangimi nelle radure e nei viali del bosco.
Anche attualmente vivono nel Gran Bosco oltre cento Cervi, forse discendenti da quelli che popolavano la pianura anticamente.
Sono in corso accertamenti genetici e sanitari per meglio conoscere e conservare questo animale. Non è molto facile per il visitatore incontrare il Cervo, per le sue abitudini ed il timore che esso ha dell'uomo. Più facilmente avvistabile è il Daino, anche perchè più numeroso del Cervo: si parla di oltre 300 esemplari.
Non esiste più il Cinghiale, reintrodotto con alcuni esemplari negli anni '50 e successivamente eliminato per i danni che arrecava alla campagna confinante.
Vivono nel bosco, e qualche volta si incontrano, Lepri, Tassi, Puzzole, Donnole. Sono state recentemente introdotte due Volpi con lo scopo di riequilibrare le popolazioni di Lepri e Fagiani, nelle quali, per mancanza di predatori, si erano diffuse varie malattie . Da alcuni anni si è avuta una progressiva diminuzione delle epidemie. E' stata notata varie volte la traccia della Lontra.
Numerosi sono gli uccelli, sia stanziali che migratori. Il Fagiano, stanziale, si riproduce regolarmente. Abbondanti i rapaci notturni: Barbagianni, Gufi comuni e Civette.
Presenti tutto l'anno, secondo le varie migrazioni, i rapaci diurni, tra cui la Poiana, le Albanelle, il Lodolaio. Sono svernanti, a migliaia, i Colombacci che trovano abbondante nutrimento dalle ghiande, soprattutto del Leccio. Sono nidificanti i Picchi (verde e rosso maggiore).
Sino a non molti anni fa il Gran Bosco era circondato dalle acque delle valli. Nei suoi canali ed al suo interno trovavano rifugio, soprattutto durante le nidificazioni, numerose specie di uccelli.
Con il prosciugamento delle valli e la conseguente modificazione dell'ambiente vi è stata una drastica riduzione di questa fauna. Per ovviare a tale inconveniente, la Gestione ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali ha provveduto a ricostruire una zona umida all'interno della riserva naturale.
In località "Elciola" è stato formato un bacino di acqua dolce della superficie di circa 6 ettari, nel quale trovano rifugio migliaia di anatidi (Germani, Marzaiole, Alzavole) numerosi ardeidi (Garzette, Aironi cenerini e rossi, Nitticore, più raramente Aironi bianchi) e non mancano Avocette e Cavalieri d'Italia. Sono presenti e nidificanti le Gallinelle d'acqua.
Frequenti durante i passi primaverili ed autunnali i Piro Piro, i Fratini, i Piovanelli ed i Pivieri. Sono ricomparse le Spatole, con soste anche di lunghi periodi, e le Cicogne. Durante le migrazioni sosta qualche branco di Oche. Nei prati circostanti sverna la Beccaccia. In tutto il Gran Bosco è vietata la caccia.
Tra i rettili innocui si trovano vari colubri (tra cui il nero Carbonaio) e la Biscia d'acqua. Presente la velenosa Vipera, anche se molto contenuta da vari predatori.
Facilmente visibile la Testuggine terrestre e, molto comune nei canali, la Testuggine palustre. Molto ricche di Rane le acque dei canali e del bacino, con presenza di ittiofauna tipica delle acque dolci e salmastre ferraresi (vi prevalgono i ciprinidi).
Molteplice la presenza di funghi con massimi in primavera ed autunno. In primavera le varie Morchelle, con le Elvelle e le Verpe, legate forse alla presenza di Frassini e Pioppi; non mancano le Amanite, tre cui le mortali Amanita verna e falloide. Nella tarda primavera l'Amanita solitaria e la rubescens, quest'ultima presente sino all'autunno.
Molto suggestivo è il Taglio della Falce, l'unica zona umida posta al limite sud del Bosco della Mesola e presenta una salinità variabile: qui le acque della Sacca di Goro si mescolano con quelle provenienti dall'entroterra. Ha una superficie di 200 ettari ed è costituita prevalentemente da canneto palustre. Dagli argini è visibile la Foce del Po di Volano con i caratteristici scanni. E' possibile, inoltre, osservare un'enorme varietà di avifauna tipica delle zone umide.
Nella località sono presenti un punto di ristoro, che è posto in un'antica tabarra, risalente al 1872, ed un oratorio di culto Mariano, costruito nel 1905. Il nome trae origine dall'omonima valle, quasi totalmente bonificata, Valle Falce: si tratta dell'ultimo intervento di bonifica dell'intero territorio nazionale.
Torna a inizio pagina