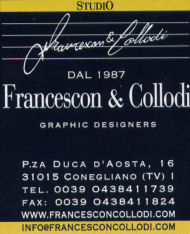L'Italia del gusto
News | Veneto | Terre d'Acqua
I lavori di una volta in campagna
Notizia del 01/06/2014
I lavori
da c'era una volta
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno e luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
La famiglia veneta fino agli anni Cinquanta si sostentava quasi esclusivamente con il lavoro nei campi, quindi la bontà dei raccolti era fondamentale per la sopravvivenza della famiglia stessa.
I lavori nei campi erano cadenzati durante 1'anno in modo ripetitivo e preciso, tanto da dettare usi e costumi della famiglia.
I mesi in cui c'era meno da fare e ci si riposava erano quelli invernali, ovvero da novembre a febbraio. Tale periodo era dedicato alla preparazione o riparazione degli attrezzi agricoli, che dovevano essere pronti all'inizio della nuova stagione. Nei mesi freddi, inoltre, si tagliavano le siepi per ricavare la legna per riscaldarsi, i pali per i vigneti e i rami per i bachi da seta.
A febbraio iniziava la nuova stagione di lavoro, con la potatura dei vigneti. A marzo cominciava 1'aratura di quei terreni che sarebbero stati dedicati a semina e la concimazione di quelli invece da dedicare a foraggio. L'aratura dei campi era svolta con strumenti rudimentali. Si usava el vassor, ovvero l'aratro, che agli inizi era in legno con il vomere in ferro e successivamente divenne tutto in ferro; la grapa, ovvero l'erpice in legno con i denti in ferro e quella tutta in ferro inanellata; i vari carri piatti, carretti a forma di parallelepipedo, carriole, forche, vanghe e rastrelli. L'aratura richiedeva l'impiego di diversi uomini: uno per el vassor, per fare i solchi, uno per i buoi e uno per il sacco per arare il terreno.
La concimazione dei terreni era detta "spander la grassa", ovvero spargere sul campo con le forche il letame posto sul carro a scalar (carro con le sponde rialzate). Servivano quattro uomini e quattro buoi. Spesso i buoi di una famiglia non erano sufficienti né per l'aratura né per la concimazione dei terreni a foraggio, quindi era d'uso tra le famiglie contadine aiutarsi vicendevolmente prestandosi i buoi gli uni con gli altri.
Il foraggio era una delle principali preoccupazioni dei contadini perché serviva per sfamare le mucche, loro fonte di reddito e di sostentamento. Il problema si presentava in particolare d'inverno, quando i campi erano sterili.
Parte dei terreni, quindi, era sempre destinata a prato, seminato spesso a erba medica (la spagna), trifoglio o erba mista, così da riuscire a fare più tagli di fieno da immagazzinare per l'inverno.
Raccolta fieno
La raccolta del fieno. Scena di raccolta del fieno nei campi, risalente agli anni cinquanta a giudicare dall'abbigliamento.
La meccanizzazione della raccolta del fieno risale agli anni settanta.
Raccolta frumento
La raccolta del frumento.
Al primo calent (calare di luna) di marzo c'era la semina delle patate, che normalmente era un lavoro femminile.
Ad aprile si procedeva alla semina del granoturco, da cui si ricavava la farina per la polenta, ovvero l'alimento base e fondamentale di ogni pasto di una famiglia contadina di quegli anni.
Questa pianta erbacea originaria del Messico venne importata in Italia agli inizi del XVI secolo. Le varietà coltivate erano due: quella primaverile (la bonoriva) e quella agostana (al cinquantin).
La qualità bonoriva era seminata ad aprile, sul terreno preparato spargendo la grassa e facendo i solchi nei quali il seminatore lasciava cadere i grani, poi ricoperti con il terreno ingrassato. Normalmente l'operazione richiedeva cinque o sei persone, tra uomini e donne.
La semina del cinquantin invece avveniva a giugno-luglio nei solchi del frumento appena raccolto, coperti poi di letame. In ambedue i casi il terreno veniva prima erpicato con la raccolta a mano della gramigna e delle altre erbacce.
A partire dal mese di maggio il contadino iniziava a lavorare a pieno regime e continuava fino a ottobre.
I campi coltivati a granoturco, che nel frattempo aveva raggiunto circa i dieci o quindici centimetri di altezza, dovevano essere zappati e ripuliti dalle erbacce in modo che le piantine mantenessero la distanza di venti, trenta centimetri l'una dall'altra.
In seguito si procedeva alla prima segada (falciatura) del fieno. La seconda segada si effettuava ai primi di luglio, la terza a settembre e l'ultima a ottobre. Invece i campi coltivati a erba medica erano falciati solo tre volte l'anno.
Falciare il prato era una delle fatiche più pesanti del contadino, ma il foraggio era fondamentale per il bestiame della famiglia. All'alba il contadino era già sul prato. Più tardi la moglie gli portava la merenda: polenta e salame o formaggio, accompagnata da un bicchiere di vino.
Quando il contadino si accorgeva che la falce non tagliava bene cercava refrigerio sotto le fronde di un albero e iniziava a batter al faldin (affilare la falce) percuotendo il filo della lama con un martello su una piccola incudine.
Il fieno tagliato e ammucchiato a ogni falciatura era disteso al sole dai familiari con la forca (destirar al fien). Dopo qualche ora il fieno era rivoltato perché si essiccasse. Nel tardo pomeriggio era raccolto in mar de fien (mucchi di fieno) distanti gli uni dagli altri cinque o più metri. All'indomani il fieno era disteso nuovamente, sempre con l'uso della forca. Infine alla sera del secondo giorno era raccolto sul carro con l'aiuto di almeno tre persone: la prima caricava il fieno sul carro, la seconda lo distribuiva al meglio e l'ultima era di guardia ai buoi.
Il fieno era generalmente raccolto attorno all'imbrunire perché con l'umidità si perdeva meno fiorame, che era la parte più sostanziosa per gli animali.
Trasporto frumento
Il trasporto del frumento.
Come già detto, il foraggio era fondamentale e non era mai troppo.
Il contadino durante l'estate falciava anche l'erba lungo i fossati, oppure andava in montagna a far fien nel mese d'agosto, ma per questo doveva presentare domanda alla Guardia forestale e aspettare che gli venisse assegnata una zona da falciare. Ottenuto il permesso, parte degli uomini della famiglia si trasferiva in montagna per una quindicina di giorni e dormiva in baracche, dette casere. I tre o quattro carri a scalar di fieno così raccolti sarebbero serviti al fabbisogno invernale del bestiame.
A maggio, infine, si iniziava anche a pompar le vide, ovvero a irrorare le viti con il pesticida. Si utilizzava una coppia di buoi, che trainava il carro a scalar su cui era disposta una botte di quattro ettolitri. Una persona si occupava di irrorare il solfato di rame sulle piante e un'altra persona serviva per l'acqua. L'operazione era ripetuta una volta a settimana fino alla fine di agosto.
Nei mesi di giugno e luglio avveniva la seconda falciatura del fieno e il pompar le vide. Poi si aggiungeva uno dei lavori più importanti: la raccolta del frumento. La raccolta richiedeva molte persone, anche otto o nove, che iniziavano a lavorare il mattino molto presto (verso le 3.00) e continuavano ininterrottamente fino a metà mattina, quando il sole rendeva il lavoro impossibile. Alla raccolta del frumento partecipavano uomini, donne, giovani, ovvero tutta la famiglia, e in caso di bisogno si andava anche in cerca di opera (manovalanza) o ci si scambiava l'aiuto tra famiglie vicine, in uno spirito fraterno e amichevole. Così ognuno si disponeva in ordine, ricurvo sul proprio solco, e canterellando e chiacchierando allegramente procedeva al taglio del frumento con la messola (la falce messoria).Con il frumento tagliato si facevano mannelli (fasci di spighe) legati con una spiga e si deponevano sul terreno formando biche (mucchi) di mannelli con il tetto (inclinato in modo che se pioveva I'acqua scolasse scendendo, senza bagnare il grano sottostante). Per la costruzione del tetto (imbignar) si disponevano in piedi tre mannelli di frumento e sopra era posto un cappello fatto con spighe aperte. Quando il frumento era ben essiccato (ovvero anche dopo venti giorni) veniva raccolto e portato con i buoi e il carro a scalar a casa per essere trebbiato.
Il campo doveva essere liberato dal frumento per procedere alla semina del cinquantin, varietà di granoturco che maturava velocemente e che per ottobre era pronto per essere raccolto e usato per sfamare gli animali.
Naturalmente le trebbiatrici erano rare, una per paese, quindi era stabilito un turno per i contadini richiedenti.
La trebbiatrice a vapore fece la sua comparsa attorno al 1920. Attorno al 1930-1935 arrivò la motoaratrice Ford dall' America, e nel 1935-1941 la macchina Diesel/Ford a spinterogeno, con messa in moto a mano e motore a gasolio.
Il frumento, una volta portato a casa, era disposto in grosse biche nell'aia oppure conservato nel biaver (granaio), se la trebbiatura avveniva casa per casa o in attesa di portarlo dal mugnaio, altrimenti rimaneva sul carro e veniva portato nella casa di chi aveva la trebbiatrice. Durante la trebbiatura tutti svolgevano in modo ordinato il proprio lavoro: uno porgeva il covone (fascio di spighe legate) alla donna accanto alla tramoggia, che con un falcetto tagliava il legaccio passandolo a un uomo che lo avrebbe infilato nella bocca della tramoggia stessa. La macchina divorava i covoni e da una "bocca" anteriore faceva uscire la paglia, mentre da dietro in un getto continuo usciva il grano, che era raccolto nei sacchi, e da altri uomini portato poi sul granaio. Il macchinista se ne stava dietro la motrice a seguire i lavori e a regolare la forza per evitare l'inceppamento. La paglia serviva per gli animali in stalla, mentre i sacchi di frumento venivano portati dal mugnaio per la macina.
Parte del frumento poteva essere venduto, ma la gran parte serviva per l'uso familiare.
Trebbiatura
La trebbiatura.
Alla fine gli operai, trafelati, sudati, coperti di polvere, si pulivano alla buona ed entravano in cucina per festeggiare la fine del lavoro. Il giorno della trebbiatura, infatti, era un giorno di festa per tutta la famiglia: l'aia veniva spazzata, la cucina pulita e messa in ordine. La tavola era imbandita da pane fragrante, vino, salame, ossocollo e pancetta per i trebbiatori.
Nel mese di agosto si continuava a togliere l'erba dai solchi del granoturco e a tagliare le zime (cime) dalle pannocchie per darle in pasto agli animali in stalla. La pannocchia era privata dalle foglie, così che maturasse più in fretta per produrre la farina per la polenta, visto che le scorte di frumento spesso cominciavano a scarseggiare.
Si arrivava così al mese di settembre e verso l'ultima settimana si iniziava la vendemmia dell'uva bonoriva, poi si continuava anche fino a novembre con altre varietà.
La vendemmia richiedeva molte persone, anche otto o nove, e come per la raccolta del frumento spesso ci si avvaleva del lavoro a opera (manovalanza).
La vendemmia era una festa familiare a cui tutti partecipavano con entusiasmo: Si partiva il mattino presto con el laguas (la rugiada), si sostava nel campo anche per pranzo e si tornava la sera tardi. Ogni famiglia, nell'andare e tornare, formava una vera processione, una carovana, con in testa i carri zeppi di cesti e di tini colmi di uva e dietro una schiera di uomini, donne e bambini. Lo svolgimento della vendemmia comportava la suddivisione in gruppi per i filari di viti. Non esisteva ancora il sistema di coltivazione delle viti a belusera, ma le piante erano singole. Gli uomini, le donne e i bambini avanzavano lentamente staccando con cura i singoli grappoli di uva dorata o nera, e li riponevano nei cesti, a loro volta svuotati nei tini disposti sui carri.
L'allegro chiacchierio, di tanto in tanto interrotto da canzoni allora in voga, riempiva l'aria carica di gioia.
Vendemmia
La vendemmia.
A casa iniziava il movimentato lavoro di pigiatura, detto pestar l'uva, che era non solo faticoso ma anche pericoloso, a causa delle esalazioni di gas all'inizio della fermentazione del mosto. L'uva pigiata era quindi messa nei tini per la fermentazione, che richiedeva circa otto giorni. Il mosto era quindi filtrato e conservato nelle botti. Ciò che rimaneva dopo questa operazione era nuovamente pigiato, per ricavarne il massimo del succo, e quindi anch'esso conservato nella botte. La vinaccia che rimaneva era utilizzata per la fabbricazione della "sgnappa" (grappa), prodotta illegalmente in casa.
Il vino così prodotto, finché non si utilizzò il sistema a belusera, era appena sufficiente per il fabbisogno familiare.
A ottobre, oltre alla vendemmia, si svolgeva anche la raccolta del granoturco cinquantin e la semina del frumento. Una volta maturo il grano turco veniva raccolto e portato a casa per l'operazione dello scaposar (spannocchiare), sebbene alcuni vi provvedessero già nel campo.
Quando spannocchiavano, le donne prestavano grande attenzione nella scelta delle brattee che sarebbero servite a fare nuovi pagliericci (sacchi pieni di paglia, foglie secche ecc usati come materasso) o a riempire quelli vecchi, mentre gli uomini separavano con un'accurata cernita le pannocchie buone dalle scadenti. Le pannocchie buone erano sgranate (sgarbar) per produrre la farina da polenta e le scadenti erano date agli animali con tutto il tutolo. L'operazione di scaposar si svolgeva solitamente la sera nell'aia, nel tardo autunno, alla luce dei lampioni e spesso con l'aiuto dei vicini.
Spannocchiare
Scaposar.
Il cinquantin era tagliato a ottobre, legato a covoni, accatastato perché si seccassee disposto nel granaio per l'utilizzo in stalla come lettiera per il bestiame o come nutrimento. Infine c'era la semina del frumento, che inizialmente era fatta a mano spargendo semplicemente le sementi sul terreno; in seguito l'operazione fu meccanizzata e si iniziò a utilizzare una macchina trainata da due buoi, che generalmente era presa a prestito. Il lavoro richiedeva una giornata.
Con il mese di novembre finivano i grandi lavori nei campi e nei successivi quattro mesi ci si riposava, nell'attesa di un nuovo anno e di un nuovo raccolto.
Torna a inizio pagina